|
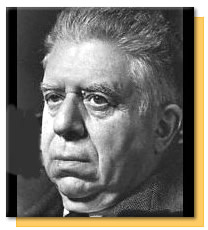 Albe
e notti qui variano per pochi segni. Albe
e notti qui variano per pochi segni.
Il zigzag degli storni sui battifredi
nei giorni di battaglia, mie sole ali,
un filo d'aria polare,
l'occhio del capoguardia dallo spioncino,
crac di noci schiacciate, un oleoso
sfrigolio dalle cave, girarrosti
veri o supposti – ma la paglia è oro,
la lanterna vinosa è focolare
se dormendo mi credo ai tuoi piedi.
La purga dura da sempre, senza un perché.
Dicono che chi abiura e sottoscrive
può salvarsi da questo sterminio d’oche;
che chi obiurga se stesso, ma tradisce
e vende carne d’altri, afferra il mestolo
anzi che terminare nel pâté
destinato agl'Iddii pestilenziali.
Tardo di mente, piagato
dal pungente giaciglio mi sono fuso
col volo della tarma che la mia suola
sfarina sull'impiantito,
coi kimoni cangianti delle luci
sciorinate all'aurora dai torrioni,
ho annusato nel vento il bruciaticcio
dei buccellati dai forni,
mi son guardato intorno, ho suscitato
iridi su orizzonti di ragnateli
e petali sui tralicci delle inferriate,
mi sono alzato, sono ricaduto
nel fondo dove il secolo è il minuto –
e i colpi si ripetono ed i passi,
e ancora ignoro se sarò al festino
farcitore o farcito. L’attesa è lunga,
il mio sogno di te non è finito.
(da La bufera e altro, in Tutte le poesie)
Traccia critica
La poesia di Montale sviluppa un ordine di rappresentazione
in cui la storia umana si risolve e dissolve prima nel
suo presupposto naturale e cosmico (Ossi di seppia,
1925), immobile campo di ricognizione del negativo;
poi, nel secondo libro delle Occasioni (1939), la modalità
del non essere, con il rischio della stessa impraticabilità
della poesia, spinge a proiettare sullo schermo figure
dell’essere, amuleti di salvezza improbabili e
fuggenti, sigilli e talismani dimentichi dell’uso.
In mezzo, la mitologia borghese del sacrificio, di un
Io perplesso e sfiduciato induce alla creazione di un
mondo diviso fra realtà e apparenza, rugosa frontalità
e sparizione.
Le due istanze metafisiche costruiscono la posizione
figurale del «prigioniero», racchiuso nella
propria bolla d’inappartenenza, Arsenio del proprio
«delirio d’immobilità». Il
terzo libro (La bufera e altro, 1956), è come
se spaccasse questi due postulati fissi e si aprisse
al dato esterno, bruciando il nichilismo del primo libro
e l’imprendibile luce da pietra preziosa del secondo,
nella più ampia problematica dell’invasione
della storia.
La «bufera», appunto. Dopo avere decantato
l’esperienza petrarchista, di poeta metafisico
con le sue figurazioni incantatorie, proietta la sua
Delia o Selvaggia sullo sfondo di una guerra cosmica
e terrestre senza senso, una tempesta di cui la poesia
è definizione e scacco insieme. Parola d’ombra
e di lamento, il declamato di Montale ex cantante lirico
si intride di ferite che straziano la sua precedente
illusoria unità, rompe cartilagini; passa il
vento terrestre del disastro, della memoria che non
salva, ma conduce la borghesia a visitare i luoghi della
propria discesa agli inferi.
Il sogno del prigioniero è la prigionia, forse
la poesia che conclude La bufera vuole annunciare proprio
questo; e quello che verrà dopo, il Montale borghese
scriba del dopo storia, sobrio e cinico insieme, archivista
del nulla, è passato dalla distruzione del tempo
che corrode, nel suo primo libro; del cancro della volgarità
umana e della guerra nell’Occasione; e degli unici
dèi possibili, quelli pestilenziali, cuochi di
una cucina mostruosa dove non sappiamo più distinguere
se siamo farcitori o farciti.
Lo spazio angusto di una cella dove spazio e tempo si
contraggono sono il teatro della storia che non finisce,
in un incubo di minimi gesti, eventi che non annunciano
niente, sfiniti ed infiniti insieme. «Albe e notti
qui variano per pochi segni». (Giacomo Trinci)
Bibliografia
E. Montale, L’opera poetica, a cura di R. Bettarini
e G. Contini, Torino, Einaudi, 1980 (o Tutte le poesie,
Milano Mondadori, 1997).
Per conoscere Montale, antologia a cura di M. Forti,
Milano, Mondadori, 1990.
Sulla poesia, Milano, Mondadori, 1997.
G. Contini, Una lunga fedeltà. Scritti su Eugenio
Montale, Torino, Einaudi, 1974.
G. Debenedetti, Montale, in Poesia italiana del Novecento,
Milano, Garzanti, 1974.
F. Fortini, Eugenio Montale, in I poeti del Novecento,
Bari, Laterza, 1977.
P.V. Mengaldo, Eugenio Montale, in Poeti italiani del
Novecento, Milano, Mondadori, 1978
A. Jacomuzzi, La poesia di Montale, Torino, Einaudi,
1978.
M. Marchi, Eugenio Montale, in Storia letteraria d''Italia.
Il Novecento, a cura di G. Luti, Verona, Piccin-Vallardi,
vol. I, 1989.
AA. VV., Montale e il canone poetico del Novecento italiano,
a cura di M.A. Grignani e R. Luperini, Bari, Laterza,
1998.
E. Testa, Montale, Torino, Einaudi, 2000.
|
|



