|
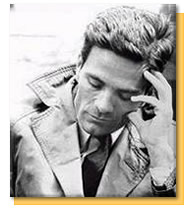 […] […]
Rendo ridicola una mia lunga passione
di verità e ragione.
Passione… Sì, perché c’è
un cuore antico,
preesistente al pensiero:
e un corpo antico – o fiorente o ferito,
povera vita mia certa davvero
di resistere alla vita informe dei nervi.
Da questo inesprimibile attrito
nasce la mia prima larva di Passione:
tra il corpo e la storia, c’è questa
musicalità che stona,
stupenda, in cui ciò ch’è finito
e ciò che comincia è uguale, e resta
tale nei secoli: dato dell’esistenza.
Il confine tra la storia e l’io
si fende torto come un ebbro abisso
oltre cui talvolta, scisso,
alla deriva, è il glorioso brusio
dell’esistenza sensuale
piena di noi: dinnanzi a questa fisica
miseria non può che ritornare
ogni storico atto irrazionale…
[…]
(da La religione del mio tempo, in Tutte le poesie)
Traccia critica
Oltre ventimila pagine, in poco più di trent’anni
di attività.
Dai lustri bolognesi e poi friulani, fino ai controversi
anni Settanta, Pasolini percorre l’ebbro abisso
di una ricerca compulsiva: quella di una parola poetica
che sappia raccontare reale e personale, sottraendoli
alla provvisorietà e cantandone l’incanto
con l’assolutezza del Verbo.
La lingua poetica in Pasolini si fa strumento di una
passione ideologica inesausta: non è solo testo
ma qualcosa che lo trascende. Da bulimico consumatore
di spunti, piega le forme della poesia a proteiformi
cimenti. Ardua risulta dunque una separazione di stili
e forme espressive per un pensiero globale come quello
pasoliniano.
L’opera di Pier Paolo Pasolini è una performance
ininterrotta che non teme di trasgredire e non cela
il suo protagonista. Pasolini non si limita ad un’idea
immutevole di poesia ma, pur variandola, non smette
di interpretarla attivamente: se nel primo Pasolini
le parole sono azioni in se stesse in quanto segni fatti
musica, l’ultimo Pasolini ne fa documenti essenziali
dell’azione.
Il poeta Pasolini esiste dunque compiutamente nell’intellettuale
Pasolini, che lascia sconfinare il pensiero nelle limitrofe
regioni dell’estetica. Anche l’esperienza
di presunta regressione degli anni friulani altro non
rappresenta che una premessa del discorso ideologico
romano: dal mythos al logos.
Del resto, proprio la questione «dialetto-lingua»
che animava gli anni di Casarsa, si ripropone iper-strutturata
nel tempo romano di Pasolini, con la difesa e la celebrazione
della componente sacrale che la realtà custodisce,
e che la lingua della realtà, dei parlanti, riproduce.
Il mito dell’incoscienza, della povertà
e del peccato, ispirati dalle esistenze più che
reali dei ragazzi romani, soppianta il topos narrativo
dell’agreste gioventù friulana, mentre
un temperamento aspramente militante inizia ad impregnare
la scrittura di Pasolini: lo stile, in quanto momento
epifanico dell’arte, assolve così una funzione
segretamente ideologica.
E anche quando, nei tardi anni Sessanta, realizza l’inconsolabile
certezza dell’inutilità della scrittura,
Pasolini non smette di interrogarsi ideologicamente
sul suo senso e di attaccarne le regole fino ad accettare
che la scrittura non miri ad altro che a qualcosa di
scritto: si affida dunque ad opere riempibili all’infinito,
incompiute e interminabili, delle quali egli è
demiurgo sempre vigile ed attivo. Un’arte libera
dai circuiti epigonali dell’industria culturale,
ma imprevedibile e sempre capace di riaprire il gioco.
Nei suoi trent’anni di eclettica, ininterrotta
espressione creativa, la cangiante tensione ideologica
di Pasolini ha sempre covato una vocazione da pedagogo
e da leader: a partire dalle stagioni della scuola di
Valvasone, dai versi di quegli anni e dai successivi,
per continuare nella corrispondenza privata e pubblica,
fino alle tarde pagine di critica militante. Ma la refrattarietà
e la ripugnanza mai edulcorata per la politica mantengono
le sue pagine sempre al di fuori di ogni militanza etichettabile.
Ciò che attiva e stimola Pasolini è piuttosto
il quotidiano, la vita comune. In questi casi il «corsaro»
si fa tagliente e lucido, il poeta canta con verso espressivo,
pregnante e incendiario: «Nel restare / dentro
l’inferno con marmorea / volontà di capirlo,
è da cercare / la salvezza».(da Picasso,
in Le ceneri di Gramsci). (Maria Sabrina Titone)
Bibliografia
L’opera di P.P. Pasolini è oggi consultabile,
nella sua interezza, nelle edizioni dei «Meridiani»
Mondadori, a cura di W. Siti e S. de Laude: Tutte le
poesie, 2003; Per il cinema, 2001; Teatro, 2001; Saggi
sulla letteratura e sull’arte, 1999; Saggi sulla
politica e sulla società, 1999; Romanzi e racconti,
1998.
Poesie scelte, antologia a cura di N. Naldini e F. Zambon,
Milano, TEA, 1997.
Poesie. Con CD-Audio, letture di S. Lombardi, Milano,
Garzanti, 2001.
G. Ferretti, L’universo orrendo, Roma, Editori
Riuniti, 1976.
E. Siciliano, Vita di Pasolini, Milano, Rizzoli, 1978
(poi Firenze, Giunti, 1995).
M. Marchi, Descrizioni di descrizioni. Il saggismo poetico
dell’ultimo Pasolini, in Palazzeschi e altri sondaggi,
Firenze, Le Lettere, 1996.
M.A. Bazzocchi, Pier Paolo Pasolini, Milano, Bruno Mondadori,
1998.
G. Jori, Pasolini, Torino, Einaudi, 2001.
F. Vighi, Le ragioni dell’altro. La formazione
intellettuale di Pasolini tra saggistica, letteratura
e cinema, Ravenna, Longo, 2002.
|
|



