|
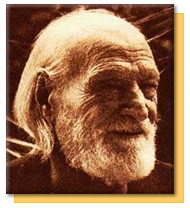 Un’intera
nottata Un’intera
nottata
buttato vicino
a un compagno
massacrato
con la sua bocca
digrignata
volta al plenilunio
con la congestione
delle sue mani
penetrata
nel mio silenzio
ho scritto
lettere piene d’amore
Non sono mai stato
tanto
attaccato alla vita
(da L’Allegria, in Vita d’un uomo. Tutte
le poesie)
Traccia critica
Giuseppe Ungaretti e L’Allegria: un poeta e il
suo «diario lirico» del tempo di guerra,
un testo capitale nella storia della poesia italiana
del Novecento, che testimonia in maniera esemplare l’inscindibilità
di poesia e vita vissuta.
Per Ungaretti l’ingresso, brutale, traumatico,
nella Storia inaugura la stagione esistenziale e poetica
riassuntivamente intitolata alla Vita d’un uomo.
Per lui, uomo venuto dal deserto senza avere conosciuto
una patria, senza sapere bene quale sia il paese –
l’Italia avita, la Francia dei poeti amati - verso
cui è diretta la sua «nostalgia»,
l’esperienza bellica al fronte degli anni 1915-18
coincide con la mèta agognata del pieno riconoscimento
di sé, della sua identità di poeta e di
italiano. Lo dichiarano splendidamente, contestualizzando
gli esiti di una ricerca, i suoi Fiumi di ieri e di
oggi («Questi sono / i miei fiumi», «Questo
è il Serchio», «Questo è il
Nilo», «Questa è la Senna»,
«Questi sono i miei fiumi / contati nell’Isonzo»).
Solo nel tempo presente, assurdo e atroce, della vita
di trincea, proprio quando la facoltà di dire
appare inaudita e impossibile, la parola si scopre «parola
originale»: quella che tutto nomina, «il
mondo l’umanità / la propria vita»,
e per mezzo della quale ogni cosa esiste e significa.
Per il poeta viator, che in una lettera a Papini del
luglio 1916 si definisce «immaginario perseguitato
in esodo verso una terra promessa», conta fin
d’ora che il viaggio ci sia, dentro e attraverso
la scrittura poetica, a indicargli il passaggio per
un «paese / innocente».
Sul Carso e poi sul fronte francese, a Locvizza, Mariano,
Cima Quattro, Versa, Quota Centoquarantuno, Valloncello
dell’Albero Isolato, Bosco di Courton, il fante
Ungaretti porta con sé i propri miti ossessivi:
dispersi frammenti di una sua biografia suscettibile
di ricomporsi nella biologia di un poeta che di sé
dice: Sono una creatura; un poeta disposto a perdersi
e a ritrovarsi in paesaggi disanimati, a fraternizzare
con pietre e rovine potendo essere insieme lì
e altrove.
Il miraggio egiziano e poi Parigi, con il miraggio della
letteratura e dell’arte, riflettono adesso un
nuovo scenario, della testimonianza e della partecipazione
all’insegna dell’immediatezza e dell’essenzialità.
La volontà di poesia risorge dalle macerie, risponde
e presta soccorso alla ungarettiana «volontà
di vivere nonostante tutto». È la metamorfosi
dell’Ungaretti protostorico, crepuscolare e futurista,
sonnambolico e ironico-incendiario, nella fenomenologia
del poeta soldato: non «un soldato (…) che
fece il poeta«, come osserverà anni dopo
Umberto Saba, ma «un poeta che fece la guerra».
Esule tra esuli all’inferno del Carso, l’«Ungaretti
/ uomo di pena» individua nella drammaticità
di una vicenda personale e collettiva l’ubi consistam
del suo mandato poetico, la cifra della propria appartenenza
ad un popolo, alle sue tradizioni, alla sua lingua.
Trovarsi da poeta dentro gli orrori della guerra, quella
guerra pure creduta necessaria, valutata improrogabile
nell’illusione, condivisa dai più, di poter
dire fine a tutte le guerre, impone di «vivere
nella contraddizione», con il coraggio e la libertà
concessi alla poesia come un privilegio infallibile
e inalterabile.
«Nella mia poesia – commenta Ungaretti –
non c’è traccia d’odio per il nemico,
né per nessuno: c’è la presa di
coscienza della condizione umana, della fraternità
degli uomini nella sofferenza, dell’estrema precarietà
della loro condizione. C’è volontà
d’espressione, necessità d’espressione,
c’è esaltazione, nel Porto Sepolto, quell’esaltazione
quasi selvaggia dello slancio vitale, dell’appetito
di vivere, che è moltiplicato dalla prossimità
e dalla quotidiana frequentazione della morte. Viviamo
nella contraddizione«.
Nel «porto sepolto», luminoso ed infero,
che custodisce il mistero insondabile della poesia,
tutto insomma, e il contrario di tutto può accadere
e accade. Ci si può sentire stranieri staccati
per sempre dalla vita, eppure mai come allora, prima
di allora tanto attaccati alla vita, con la certezza
di avercela fatta. La «parola / scavata»,
nella vita e nella scrittura, «come un abisso»,
rivela al poeta se stesso; lo riporta alla coscienza
della sua «allegria» come unico orizzonte
di salvezza, mentre il viaggio faticosamente ma senza
indugio riprende, verso quel punto di fuga in cui solo
è speranza d’approdo.
Una «vita d’un uomo» ancora in gran
parte da scrivere o da riscrivere (ma già profilatasi
nelle sue istanze germinative e fondanti) subito si
fa libro, opera aperta; un libro costantemente aggiornabile,
nelle cui pagine a venire il mito avantestuale dell’innocenza
ed il recupero della memoria delineano complicità
non sospette in seno ad una ritrovata capacità
di canto.
Così, anche dopo il naufragio delle ideologie,
dopo l’esperienza intima e straziante del Dolore
e l’altra, analogamente partecipabile della conversione
religiosa, la poesia ungarettiana manterrà la
sua capacità di attraversamento della Storia
fedele alla sua chiamata originaria: sempre a ridirsi,
a risillabarsi la parola «vita». (Nicoletta
Mainardi)
Bibliografia
G. Ungaretti, Vita d’un uomo. Tutte le poesie,
a cura di L. Piccioni, Milano, Mondadori, 1969.
Vita d’un uomo. Saggi e interventi, a cura di
M. Diacono e L. Rebay, Milano, Mondadori,1974.
Poesie e prose liriche, 1915-1920, a cura di C. Maggi
Romano e M.A. Terzoli, introduzione di D. De Robertis,
Milano, Mondadori, 1989.
Per conoscere Ungaretti, antologia a cura di L. Piccioni,
Milano, Mondadori, 1971.
G. Luti, Invito alla lettura di Ungaretti, Milano, Mursia,
1974.
P.V. Mengaldo, Giuseppe Ungaretti, in Poeti italiani
del Novecento, Milano, Mondadori, 1978.
C. Ossola, Giuseppe Ungaretti, Milano, Mursia, 1975
e 1982.
M. Marchi, Ungaretti e l’innocenza, in Pietre
di paragone, Firenze, Vallecchi, 1991.
M. Barenghi, Ungaretti: un ritratto e cinque studi,
Modena, Mucchi, 1999.
A. Cortellessa, Ungaretti, Torino, Einaudi, 2000.
|
|



