| |
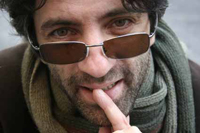 Quel
giorno, il 23 ottobre del 1977, mia madre mi fermò
all’improvviso e mi mise un brutto cappello di colore
marrone con i paraorecchi. All’epoca non truccavo
ancora i motorini né impennavo per le vie del centro.
Ero un delicato ragazzino undicenne e mia madre tendeva
a proteggere la mia salute. Da qualche istante cadeva
la pioggia. Quel
giorno, il 23 ottobre del 1977, mia madre mi fermò
all’improvviso e mi mise un brutto cappello di colore
marrone con i paraorecchi. All’epoca non truccavo
ancora i motorini né impennavo per le vie del centro.
Ero un delicato ragazzino undicenne e mia madre tendeva
a proteggere la mia salute. Da qualche istante cadeva
la pioggia.
23 ottobre 1977, domenica. Ricordo anche l’ora:
le
17.05, perché mio padre, che se ne stava seduto
su una panchina, pronunciò la sua frase consueta,
giusto un attimo prima che mia madre mi mettesse questo
brutto cappello marrone. Con i paraorecchi:
«Si è fatta ora».
Poi guardò l’orologio e appunto disse:
«Sono le cinque e cinque».
Una vecchia consuetudine di mio padre, prima diceva che
era tardi, poi guardava l’ora. Non che una frase
così fosse prerogativa solo sua. Tutti i padri
dei miei amici prima o poi dicevano:
«Si è fatta ora».
E nemmeno loro guardavano l’orologio, ovviamente.
Non ho mai capito se intuissero meglio di tutti gli orologi
al quarzo il tempo che ci restava per giocare, oppure
si buttavano a indovinare, nel senso che misuravano il
tempo sulla loro capacità di sopportare ancora
i nostri giochi. Non che non amassero i figli. È
che noi figli eravamo un accidente capitato troppo presto.
Eravamo arrivati poco prima dei loro trent’anni,
quasi a farlo apposta. Sì, perché si erano
appena affrancati da un’infanzia contadina. Il posto
fisso, un po’ di soldi in banca, gli spiccioli per
offrire la sfogliatella o il caffè agli amici,
la macchina comprata a rate. Che veniva ancora lavata
tutti i sabati pomeriggio, a mo’ di buon auspicio
per la settimana a venire. Insomma, quando i figli erano
arrivati era come se per loro fosse appena iniziato il
tempo del divertimento. A questi padri, seduti sulle panchine
dei parco giochi, toccava non solo rinunciare allo stadio
e compensare il tutto ascoltando «Novantesimo minuto»
con l’auricolare, ma dovevano pure badare a noi,
figli cagionevoli. Mio padre poi di mestiere faceva il
poliziotto e, diciamo così, la dimensione famigliare,
gli affari domestici, gli andavano stretti.
Lui scalpitava per stare sempre fuori.
Questa mancanza di tempo per loro stessi causava un principio
di irriquietezza, desideravano fuggire. Non per sempre,
si intende. Diciamo che tendevano ad anticipare l’ora
del rientro. Sottraendo qualcosa a noi, forse potevano
sperare di guadagnare qualcosa per loro:
«Si è fatta ora».
Prima che davvero si fosse fatta ora.
Comunque stavo insieme ad altri bambini in un parco giochi
vicino Caserta, un posto riadattato da poco (e, secondo
gli amministratori, migliorato) con orrendi mostri di
alluminio: scivoli, altalene e pertiche. All’improvviso
venne a piovere. Pioggia è un’esagerazione,
cadeva una pioggerellina sottile, ma tuttavia abbastanza
fitta per preoccupare le madri. Se da un lato i padri
tendevano a dire che l’ora era giunta e dunque il
nostro tempo compiuto per sempre, le madri,
al contrario, volevano assicurarci un surplus temporale.
Badando naturalmente a che ci conservassimo in buona salute.
Altrimenti era tempo sprecato.
Così a me fu messo il cappello con i paraorecchi
(che in quegli anni andava di moda) e ai miei amici il
maglioncino di lana. Poi qualcuno ci disse di andare tutti
sotto lo scivolo, per ripararci, appunto, da questa pioggia.
La salute. Dunque, la protezione prima di tutto. Noi bambini
ci sentivamo dominati da due umori contrastanti:
«Si è fatta ora!»
«Mettiti la maglia».
Due modi per dire la stessa cosa: fermati, il tempo si
è compiuto, da ora si cambia passo.
Fatto sta che mentre eravamo tutti rintanati sotto lo
scivolo, bambini e genitori, padri scocciati e madri preoccupate,
arrivarono quelli della banda di via Trento, comandati
da un ragazzo che poi sarebbe stato chiamato Peppe u’stuort.
Per via che era brutto, basso e storto, eppure dotato
di una forza incredibile. In seguito l’avrei visto
atterrare facilmente giocatori di basket. Ora, quelli
della banda di via Trento erano brutti ma vitali, praticamente
nudi, senza cappelli né maglioncini di lana.
Dovettero trovarsi davanti un’immagine lirica, che
io stesso per anni ho rivisto nei miei sogni: un parco
giochi tutto per loro, dal momento che i suoi abituali
frequentatori – ragazzini di media borghesia –
stavano rintanati sotto uno scivolo, bloccati non tanto
dalla pioggia, ma da due moti di comando diversi e uguali
al tempo stesso.
A un certo punto presero d’assalto l’altalena.
Si dondolavano in piedi sull’asse, e naturalmente
raggiunsero punte oscillatorie molto elevate. Senza temere
l’equilibrio precario, anzi. Ci fu un momento particolare,
poi, quando un colpo di vento fece volare parecchi soffioni
e i ragazzi cominciarono a inseguire i soffioni per tutto
il parco. Anche questa è stata un’immagine
che di seguito avrei rivisto nei miei sogni. Non c’è
che dire, erano felici, sotto la pioggia, quasi nudi,
andavano su e giù senza paura.
«Senza paura», fu un concetto che mi venne
in mente allora. Adesso, con il senno di poi, direi: senza
tempo. Per loro sembrava che l’ora non scoccasse
mai. Io, rintanato sotto lo scivolo, costretto a portare
il cappello marrone con i paraorecchi, li guardavo. Non
dovevano avere né padri che decretevano la fine
dei giochi, né madri che li appesantivano con i
vestiti. Forse adesso esagero con la visione, ma davvero
quella scena, quell’appropriazione legittima di
uno spazio lasciato vuoto, mi fece pensare: prima o poi
li devo conoscere, Peppe u’ stuort e la sua banda.
Per liberarmi dal mio maglioncino di lana, dall’ora
che scocca, dalla paura dell’eccessivo dondolio
dell’altalena. Dalla paura di smarrire l’equilibrio,
insomma.
«Mo’ si è fatta veramente ora»,
disse mio padre.
Sul finire degli anni Settanta le strade del mio quartiere
non erano ancora asfaltate. Spesso cominciavano bene e
finivano nel fango. Colpa della tipologia urbanistica.
La città andava verso la campagna, cioè
le case venivano costruite ai margini di campi coltivati
a tabacco o a canapa, così le strade non sempre
conservavano l’asfaltatura. Man mano che si inol
travano per campi e campetti subivano un processo di erosione,
l’asfalto finiva e cominciava l’acciottolato.
Poi, nei giorni di pioggia, la terra assorbiva acqua e
si formavano dei veri e propri laghi.
Un giorno capitò a me di attraversare uno di questi
laghi.
Una specie di sfida con gli amici. Oltre il confine del
lago c’era la campagna aperta. Avevo tredici anni,
da lì a poco mi sarei rotto un braccio impennando
con la bicicletta. Ma stavo acquistando coraggio. Il coraggio
di non ritirarmi proprio all’ora stabilita e di
legarmi il maglioncino in vita. Così, con la mia
bicicletta da cross mi avventurai tra il fango, e piano
piano, senza mai mettere i piedi per terra, ce la feci.
Guadai la sponda del lago e mi voltai indietro: i miei
amici, dal confine opposto, applaudivano. Ai loro occhi
dovevo sembrare contento. Dovevo, sì. Perché
mi resi conto che era stata tutta fortuna. Insomma, non
ci credevo. Nemmeno adesso saprei dire come, con quale
tecnica, avevo attraversato il lago senza impantanarmi.
Il fatto è che queste fortune finiscono per diventare
delle vere e proprie sfortune. Riuscire al primo colpo
in un’impresa può aumentare la consapevolezza
della tua impotenza.
Per questo rimandai il momento del ritorno e mi feci un
giro per la campagna. Mi inoltrai tra gli alberi e i cespugli.
Ricordo ancora le grida dei miei amici, che tornassi indietro,
si era fatta ora, stava scendendo il buio. Però
avevo più paura di riattraversare il lago che del
buio, e così mi allontanai solo un po’ tra
i noci. Tutto preso a osservare questo paesaggio ignoto,
non mi accorsi che davanti a me c’era Peppe ‘u
stuort e un suo amico, Filippone, figlio di un piccolo
boss che allora non si era ancora fatto largo.
Peppe mi stava puntando una fionda all’altezza della
gola.
L’elastico era tesissimo e nella fondina c’era
una pietra bianca. Per guardare la fionda, non mi accorsi
che Filippone stava partendo con un pugno. Mi prese tra
lo zigomo sinistro e il naso. Vidi una luce bianca. Per
la botta, smontai dalla bicicletta e feci due, tre passi
indietro. Non appena la luce bianca si spense rividi come
in un miraggio mio padre sedu to su una panchina con l’auricolare
che diceva:
«Si è fatta ora».
Ancora oggi, quando gioco a wrestiling con Alfredo, se
solo un pugno mi sfiora il naso, risento quello stesso
dolore di allora. E vorrei dire: «Si è fatta
ora».
«Posa ’lloco a’ bicicletta», disse
Peppe u’ stuort.
Mi scorreva tanto di quel sangue che pensavo di non avere
più il naso, per poco non abbassai lo sguardo per
cercarlo. Poi gridai: «Adesso chiamo a mio padre
che fa il poliziotto!»
«Ma chi devi chiamare, strunz’!», mi
disse Filippone. Che poi aggiunse, indicando con il dito
il mozzo della ruota: «ma a che ti serve quella
cosa lì?»
Con il dolore al naso, il sangue che scorreva, dovetti
spiegare a Filippone e a Peppe u’stuort a cosa servisse
quella roba li, attorno al mozzo. Era un’invenzione
di mio nonno, che di mestiere faceva il capo mastro. E
siccome mio nonno era ingegnoso, aveva preso un pezzo
di camera d’aria, l’aveva chiuso ad anello
e avvolto attorno al mozzo. Le strade erano fangose, la
città andava verso la campagna, c’era polvere
e detriti dappertutto. E questi ultimi, soprattutto, tendevano
a incrostare il mozzo delle ruote. In questo modo, invece,
quella camera d’aria montata ad anello, girando
attorno al mozzo, lo ripuliva. Così, mentre la
maggioranza delle ruote avevano mozzi sporchi, il mio
era lucido.
I nonni in quegli anni erano pressapoco tutti come il
mio, sapevano come controllare il mondo materiale, migliorandolo
per quello che potevano. La camera d’aria poteva
essere l’elastico per la fionda ma anche un anello,
diciamo così, con funzioni ecologiche. Si ingegnavano
parecchio. Non erano irrequieti. L’inquietudine
era un’astrazione che non faceva per loro. Se a
un certo punto lo diventavano, inquieti, si mettevano
a pensare e producevano un piccolo oggetto che migliorava
gli incastri tra le cose e il mondo.
Con il dolore al naso e tutto il resto appresso, spiegai
a Filippone e a Peppe u’ stuort a cosa servisse
quell’anello.
«Lo vogliamo pure noi», dissero.
E lo ebbero, glielo regalai io stesso: mio nonno, di anelli
così, ne produceva in quantità industriale.
Diventammo amici e realizzai il desiderio espresso durante
quella domenica pomeriggio nel parco. Non sospettavo ancora
che ogni volta che si avvera un desiderio, la nostra immaginazione
subisce un collasso. Fu così anche per me.
Gli anni Ottanta si aprirono su una ruota sola. Avevo
imparato a impennare guardando Peppe e Filippone che,
oltre a fare questo, chiedevano motorini in prestito.
Era come se volessero provare tutto e, provando tutto,
fossero in grado di mantenere il controllo su ogni cosa.
Chiedevano un motorino, se il proprietario protestava
riceveva una capata sul setto nasale e vedeva la luce
bianca, la stessa che avevo visto io, infine cadeva per
terra e perdeva il motorino. Se andava bene, l’avrebbe
avuto indietro dopo qualche giorno.
Andare su una ruota, truccare i motorini, e cioè
cambiare carburatore, cycler, marmitta, testata, pignone
erano le cose che facevo in quegli anni. Il mio motorino
da 50 cc era passato a 150 cc. e impennava pure in quarta,
tanto che avevo dovuto zavorrare la forcella. Quando non
stavo in sella, mi sedevo sul muretto a guardare Peppe
che prendeva a pugni la gente. Mi comportavo da tifoso,
incitavo la rissa. Mi faceva sempre un certo effetto osservare
la genesi della violenza.
Quando qualcuno voleva fare a botte con Peppe, prima bestemmiava
e poi lo riempiva di insulti. Non sapeva che aveva già
perso. Peppe non diceva nemmeno una parola, colpiva in
silenzio mentre il suo avversario si agitava. Non c’è
che dire, vedere come la bestemmia si spegneva in corpo,
immaginare la luce bianca che il tizio stava vedendo in
quel momento, mi dava un certo piacere.
Un giorno, dopo una piccola rissa, Ferdinando Citarella,
uno che stava nel nostro quartiere, fermò mio padre,
che stava rientrando a casa, e gli disse: «Pietro,
ma voi poliziotti che combinate? Li vedete o non li vedete
queste cape di cazzo che fanno?»
Le cape di cazzo in quel momento stavano sedute sul muretto
ed erano nella fattispecie Peppe e Filippone, anche se
Citarella guardava pure me. Per lui facevo parte della
banda. Il che, in fondo, mi onorava. Però mio padre,
dopo aver compiuto il suo solito gesto, cioè quello
di buttare la sigaretta quando qualcuno gli parlava, per
una sorta di antica creanza, creanza che in verità
gli dava parecchio sui nervi, disse: «Ferdinando,
ma tu veramente fai?»
E poi guardò le ruote dei motorini di Peppe e Filippone:
attorno al mozzo c’era l’anello autopulente,
fatto con la camera d’aria, e per questo il mozzo
era lucido, quasi brillava.
L’invenzione di mio nonno aveva avuto il suo successo
nel quartiere, una specie di status symbol.
«E secondo te, questi sono dei problemi? Questi
qua, sono due che fra qualche anno moriranno uccisi. Perché
li vedi dalla faccia che più di questo non possono
fare. Fra poco si fa ora anche per loro».
Poi guardò me e mi prese sotto il braccio: «Per
quanto riguarda mio figlio, questo è un problema
mio, fastidio non dà, evverò?»
Intanto gli anni Ottanta avanzavano a gran forza, da alcuni
anni avevo perso i miei nonni. Quando ripensavo a loro,
avevo davvero l’impressione che quel decennio stesse
cambiando il corso delle cose così come ero abituato
a conoscerle. Venne meno quel mondo sì materiale,
ma misurato e ingegnoso. Quel tipo di ingegno minimo che
inventava anelli di gomma per i mozzi. Non è che
mancasse all’improvviso la praticità. Ma
tutto quello che mi circondava sembrava o immateriale
o troppo materiale. A volte l’una e l’altra
cosa insieme. Ogni cosa fuori misura. Desideravamo tutti
grinta e potenza, rombo e tuono. Perdipiù, la potenza
si stava diffon dendo dall’alto in basso. Alcuni
padri avevano cambiato lavoro: adesso maneggiavano titoli
azionari, immateriaili, e compravano ville in collina,
molto materiali. La città, che prima andava verso
la campagna, adesso saliva su, in collina. Le strade erano
tutte asfaltate.
Mio padre invece no, mantenne il suo lavoro da poliziotto.
Certo il senso, e per così dire il vettore, del
suo lavoro cambiò. Prima girava con la volante
su e giù per la città, si caricava in macchina
qualcuno, un giovane eversivo però figlio del vicino
di casa, un altro che aveva picchiato la moglie però
in fondo le voleva bene, persone così, le prendeva
e se le portava in questura. Poche chiacchiere, poche
frasi, tra cui una ricorrente, e molto minacciosa: «Ti
sporco la fedina penale».
Finché un commissario se ne veniva, e diceva: «Si
è fatta ora, ce ne vogliamo andare a casa?»
Ma tutta questa, diciamo così, domesticità
poliziesca, ingegnosa e provinciale al tempo stesso, stava
per finire. Avanzava qualcosa di non domestico, chiamata
dai futuri teorici dell’economia: flusso immateriale
di denaro. Sì, cominciarono a girare più
soldi e bisognava controllarne la fonte. In quegli anni
a mio padre toccò di verificare i soldi che giravano
attorno al mercato della frutta. Che era in crisi, troppa
offerta e poca domanda. Così, per mantenere il
prezzo stabile, la merce doveva essere distrutta. Sempre
la stessa canzone.
Per compensare le perdite, si davano dei contributi agli
agricoltori. La questione era semplice: si aprivano centri
di raccolta, in pratica discariche a cielo aperto con
bilance per pesare la frutta che arrivava con i camion.
Si pesava la merce e la si accantonava. Alla fine le ruspe
distruggevano il prodotto. Mio padre doveva controllare
questo flusso di merce che finiva in discarica. Ma erano
gli anni Ottanta, e tutto sembrava smaterializzarsi da
un lato e materializzarsi dall’altro.
La merce aumentava misteriosamente di volume. I camion
che entravano nei centri di raccolta portavano a occhio
1000 quintali di pesche, ma non si sa come la bilancia
ne pesava almeno il triplo. Merce immateriale, ovviamente.
La merce in eccesso generava soldi in nero: più
frutta immateriale più soldi venivano erogati,
più certe persone si arricchivano e più
si acquistavano oggetti materiali. Materiale vs immateriale,
immateriale vs materiale. Gli addendi, anche se lottavano
fra di loro, producevano sempre lo stesso risultato: soldi.
Mio padre si fece il sangue amaro. Quel modo di dire:
«si è fatta ora», aveva perso il suo
significato originario. Non si potevano più accompagnare
i figli a casa e godersi la vita, bisognava rimanere a
controllare la merce. La sua irrequietezza giovanile aveva
cambiato passo. A dir la verità mio padre ebbe
proprio la sensazione che l’ora fosse fuggita, per
lui e per gli altri come lui. Non volendo adeguarsi ai
tempi, si trovò in breve fuori dal tempo. La sua
domesticità con i delinquenti abituali si perse.
In quegli anni mio padre cominciò a odiare tutti,
e non solo i violenti, i bizzosi, i camorristi, le cape
di cazzo, quelli che non volevano rispettare nessuna regola,
ma le persone in generale. O erano troppo simpatiche,
e quindi ti volevano fare fesse, o troppo attente, e allora
dovevi pararti il culo, o troppo disattente, e quindi
non si rendevano conto dei problemi. Poi mio padre incominciò
a prendersela anche con quelli che non c’entravano.
Scelse la linea dura. Si arrabbiava fuori misura, alla
violenza rispondeva con la violenza, e a fine giornata
tornava a casa che sembrava un pazzo. Tutti in famiglia
ci andammo per sotto. Collasso dell’immaginazione.
«Che brutta cosa ’a gente». Da allora
in poi fu la sua frase preferita. Ma in quel periodo il
collasso dell’immaginazione interessò tutti
in famiglia. Mio padre, come dicevo, mia madre appresso
a mio padre, e io, che adesso rinunciavo sì ai
maglioni di lana, ma non facevo altro che stare seduto
su un muretto ad aspettare Peppe e Filippone per fare
un po’ di bordello insieme. Impennare, sgasare,
sfrizionare e disegnare i cerchi con la ruota del motorino.
È come se gli ingredienti che prima ci rendevano
le cose familiari, soffici, morbide, accoglienti, fossero
misteriosamente cambiati. Ce ne accorgemmo in un giorno
di aprile dell’82, quando mia mamma mise nel forno
il pan di spagna. Ricetta semplice, tradizione di mia
nonna: farina, tuorlo d’uova e lievito. Ebbene,
il pan di spagna non cresceva, non lievitava. Se qualche
anno prima si gonfiava tanto da sembrare un pallone lasciato
al sole, adesso rimaneva basso. L’operazione culinaria
fece impazzire mia madre, che per tutto il giorno contò
e ricontò gli ingredienti, pesò e ripesò
il materiale. Pensava di avere sbagliato la dose. Non
era così. La dose era giusta, ma il pan di spagna
da quel giorno non sarebbe cresciuto più come una
volta.
Tutti in famiglia ce ne rendenno conto, ma nessuno di
noi
elaborò un pensiero sull’accaduto. Togliemmo
lo sguardo
dal forno con la sensazione che le cose fossero cambiate.
Ognuno tornò alle proprie occupazioni.
Del resto, il tempo degli oggetti che si incastravano
l’uno
con l’altro grazie al lavoro preciso dei nonni era
finito. Il pan
di spagna che cresceva aveva fatto il suo tempo.
«Si è fatta ora». Appunto.
Finché, almeno per me, non accaddero due cose.
Una di seguito all’altra. La prima fu che Peppe
ruppe senza nessuna ragione una bottiglia in testa a un
barbone. La seconda fu che andai al teatro. Le due cose
sono a tutti gli effetti collegate.
Anche per Peppe e Filippone era finito il periodo dei
giochi: i motorini, i toraci nudi al vento, i parchi da
frequentare sotto la pioggia quando gli altri erano ben
riparati. Quella bottiglia spaccata in testa al barbone
serviva a testare la nostra resistenza, la capacità
di sottomettersi al capo. Lo spirito di identificazione,
il gruppo, l’organizzazione. Se avessimo superato
la prova saremmo entrati a far parte di un giro più
grande.
Fui tra quelli che non superò la prova. Non nel
senso che mi ribbellai tout court la sera stessa. Anzi,
mi misi a ridere insieme agli altri.
Però mai risata fu per me più amara di quella.
Risi perché non avevo parole per rispondere a ciò
che avevo visto. Provavo fastidio e nello stesso tempo
ero incapace di dichiararlo. Crollo dell’immaginazione.
La porta principale per il conformismo. Accettare la stessa
logica del tuo nemico, il suo stesso stile. Una furbata.
Le furbate sono come le stronzate, alla fine si pagano
sempre. Negli anni Ottanta ci credevamo tutti molto furbi,
e invece eravamo vittime di un calo dell’immaginazione.
Troppi desideri già pronti chiedevano solo di essere
presi e consumati. Ma accadde questa benedetta seconda
cosa: il teatro. Con la scuola andammo a vedere La tempesta
di Shakespeare. Niente di raffinato, anzi. Una compagnia
di terz’ordine, più guitti che attori. Un
matinée, insomma, con una decina di classi costrette
a vedere lo spettacolo. Accanto me, sul loggione, venne
anche Peppe. Non mi fece molto piacere vederlo, non tanto
per quella storia della bottiglia rotta in testa al barbone.
In fondo non ce l’avevo con lui. Il fatto è
che mi ricordava la mia impotenza. Comunque, non appena
l’attore uscì sul proscenio, Peppe cominciò
a fischiare e, praticamen- te, metà loggione lo
seguì. L’attore non riusciva a dire nem-
meno una battuta, sommerso com’era dai fischi, dai
buuu, e cose di questo genere. Finché quest’attore
di terza categoria, un guitto, senza nemmeno il fisico
per fare Prospero, si fermò e disse con voce amara:
«Ragazzi, lo so che non vi hanno mai insegnato ad
amare il teatro, ma, ve lo dico con il cuore, non fate
gli stupidi, perché il potere vi vuole stupidi».
La magia della Tempesta cominciò da quella battuta
fuori testo. Perché ci fu un applauso liberatorio
– dopo di che, per incanto, si fece davvero buio
e silenzio in scena, nessuno disse più una parola.
Nemmeno Peppe, il quale dopo una mezz’ora lasciò
il suo posto e lasciò anche me libero dalla sua
presenza, e dunque per la prima volta vidi La Tempesta.
Che adesso, lo so, faceva pena. L’allestimento,
dico, ma allora su di me ebbe una fascinazione notevole.
«Il potere vi vuole stupidi».
Una cosa anche banale da dirsi, eppure fu come se attraverso
quella frase fossi entrato nello spirito della commedia.
Cioè, detta in breve, fu come ritrovare l’immaginazione.
Per la seconda volta sentii il desiderio di ribellarmi.
Dopo quella domenica al parco, quando guardando Peppe
e la sua banda giocare felici sotto la pioggia, pensai
di togliermi una volta per tutte il cappello con i paraorecchi,
ora al contrario desideravo liberarmi di Peppe.
In sostanza fu come riattraversare il lago di fango, ma
in
senso contrario.
Quando, dopo quella mattinata passata al teatro, riattraversai
simbolicamente il lago di fango e tornai a casa, piano
piano iniziai ad allontanarmi anche da Peppe e Filippone
e, per contrasto, mi avvicinai ad amici che leggevano
molti libri. Perché il potere ci vuole stupidi,
e non volevo più essere stupido. Nel giro di pochi
anni diventai un ragazzo colto che amava stupire tutti,
soprattutto le ragazze, con citazioni sempre indovinate.
La giovinezza, l’amore, la vecchiaia, la morte,
la desolazione, la fame del mondo, il comunismo e il fascismo,
il marxismo e l’anarchismo, per tutti questi temi
trovavo la giusta chiosa, l’ottimo commento a piè
di pagina.
Ora non guardavo più la gente, mi appartavo per
leggere.
Il massimo di questa insania, ricordo, la raggiunsi un’estate
a Tropea. Seduto sul balcone di casa senza mai scendere,
mi lessi il Viaggio al termine della notte. Mio padre
si faceva venire il sangue amaro, perché avevano
fatto tanti sacrifici per quella vacanza e, visti i rfisultati,
cioè il modo in cui io ne godevo, avremmo potuto
anche restarcene a casa. Dopo qualche tempo presi la maturità
scientifica con buoni voti, grazie anche a una risposta
particolarmente azzeccata data all’esame sul romanticismo,
e comunicai alla commissione che non avevo assolutamente
idea su cosa fare da grande. Me ne andai in vacanza a
Marina di Camerota, anche per meditare sul futuro, e portai
con me le lettere di Cechov. Una me la ricordo ancora:
«Non dubito che le scienze mediche mi abbiano tenuto
sempre all’erta. Dovunque ho potuto mi sono sforzato
di attenermi ai dati scientifici. Quando non è
stato possibile, ho preferito non scrivere affatto».
Sarà che le cose importanti non si ricordano perché
diventano parte di noi stessi e non un oggetto distante
di cui avere nostalgia, sarà per questo o per altro,
eppure quella lettera di Cechov mi fece ricordare mio
nonno e le piccole misurazioni che consentono di capire
il mondo. Così, al ritorno dalla vacanza, andai
dai miei e dissi che volevo fare agraria, perché
volevo misurare il mondo. Mio padre disse: «Agraria.
Buono. Un po’ di terra ti farà bene. Altro
che libri».
Se, per esempio, nei paesi dei Mazzoni ci arrivate dall’alto,
vedrete una figura geometrica molto semplice, un paesaggio
agricolo composto da appezzamenti di terreno trapezoidali
di 3 o 4 ettari, colore verde chiaro se si tratta di mais
(lo trinceranno per il bestiame), verde scuro se si tratta
di medica, o magari un prato misto (tre sfalci all’anno,
sempre ad uso zootecnico). Più avanti, verso il
mare, gli appezzamenti si rimpiccioliscono, 1-2 ettari,
e cambiano colore: sono frutteti o meleti (qui si fa l’annurca,
mela arcaica, piccola e buona) o drupacee (pesche primizie,
albicocche). Non ci sono più i pomodori (San Marzano)
perché il virus del mosaico li ha distrutti (per
il suddetto non c’è alcuna profilassi valida,
tranne gli ogm, ma noi italiani siamo tutti ambientalisti,
alle raffinate novità della scienza preferiamo
ancora la brutalità della chimica). I paesi dei
Mazzoni, invece, si estendono più o meno compatti
(a casa segue casa), raggrumati (sembrano generati da
una stessa matrice). Se invece ci arrivate dal basso,
vi accorgerete che i paesi sembrano antichi e allo stesso
tempo moderni. Ci sono case costruite con mattoni di tufo
e intonaco grezzo, e ville enormi, inaccessibili, ben
curate, talmente piene di orpelli architettonici (torrette,
verande, colonne doriche, capitelli corinzi, antenne paraboliche)
che penserete di essere entrati in un corridoio spazio-temporale
e poi sbucati sul Sunset Boulevard. Io ci arrivai il 26
ottobre del 1988, alle ore 10.45. Senza maglioncino di
lana, con jeans e maglietta di cotone pesante. Capelli
al vento. E molto su di umore.
Ero stato assunto per rimettere in piedi una grande azienda
abbandonata da tempo. Mio padre aveva preso la notizia
con indifferenza. Non riuscivo a capire quale sentimento
lo dominava. Anche se poi, di questa mia assunzione aveva
detto un gran bene. Non a me però, a un suo collega.
Fatto sta che con jeans e maglietta, prima di passare
in azienda, passai in un bar per un caffè. Ero
giovane e abbastanza spensierato, perciò feci finta
di niente quando il barista mi lanciò il caffè
quasi addosso, né me la presi più di tanto
quando dei ragazzini, molto simili a Peppe u’ stuort
e Filippone, passandomi vicino mi dettero un lieve ma
preciso calcio negli stinchi.
Feci finta di niente anche quando una Range Rover attraversò
i campi ancora non arati sollevando un turbinio di polvere,
e si diresse verso di me.
«Carissimo ingegnere», mi disse il tizio sceso
dalla Range
Rover. Maglione di lana e pantaloni di fustagno. Incredibile
pensai, un contadino che ha freddo, e dissi:
«Non sono ingegnere».
«Ma come? Non siete quello che comanda l’azienda?»
«Sì, in un certo senso».
«E allora siete ingegnere, io sono Peppe Mastrangelo,
vostro vicino d’azienda. Andiamoci a prendere un
caffè».
«In verità l’ho appena preso».
«E ce ne prendiamo un altro. Che è? Tenete
il fegato delicato?»
Peppe Mastrangelo parlava poco e non sapeva scrivere.
Un giorno mi fece vedere una domanda fatta per ottenere
un
contributo. Aveva una grafia tutta ariosa, senza punti
fermi,
ondulata oppure spezzata. La grammatica era inesistente.
Dovetti riscrivergliela io e lui fu molto contento. Fatto
sta che, analfabetismo o meno, Mastrangelo divenne una
presenza rassicurante fin da quel primo giorno. Dopo che
mi portò a prendere il caffè, né
il barista né i ragazzini mi trat- tarono male.
Grazie a lui trovai ottimi rivenditori di concimi e diserbanti.
Sapevo anche dove comprare la mozzarella buona, quella
calda, piena di latte, oppure dove mangiare il pesce senza
spendere molto. A dire la verità grazie a lui non
spendevo niente, la mozzarella era sempre offerta, il
caffè pagato e al ristorante c’era sempre
un trattamento di favore.
In azienda non avevo niente, né attrezzi né
macchine, dovevo delegare tutto a conto terzi. Il primo
anno presi uno di nome Spizzuoco, un tizio che aveva una
piccola ditta e qualche operaio. Spizzuoco era divertente,
mi portava su e giù per i Mazzoni nella sua Mercedes.
«Ingegnere carissimo», mi diceva sempre. «Ma
non sono ingegnere...» Una volta mi raccontò
che era stato a Lourdes. Una giornata piovosa, veniva
giù un sacco di acqua. Lui se ne stava sotto la
pioggia e la moglie gli disse: «Spòstati».
«Se la Madonna non vuole che mi bagni, non mi bagnerò».
E sosteneva, infatti, di non essersi bagnato. Il problema
fu che Spizzuoco, a furia di raccontare storie di miracoli
e scorazzarmi per i Mazzoni, in azienda fece poco e niente.
Così l’anno appresso lo licenziai, e presi
due fratelli di cognome Cunto (i loro nomi non li ho mai
saputi) che venivano dagli ameni monti del Matese. Bravi,
semplici e lavoratori. I quali subito si diedero da fare.
Arararo, erpicarono e a dicembre si preparano a seminare.
Quando, il 23 dicembre, alle dieci di sera, mi arriva
una telefonata a casa da parte di uno dei due Cunto:
«Ingegnere, oggi non abbiamo potuto fare niente».
«Ah! E come mai?»
«Spizzuoco è venuto con due cape di cazzo
e ha detto che se non bloccavamo i lavori metteva le bombe
sotto le macchine».
Ora, quello che capii dopo la telefonata di uno dei due
fratelli Cunto fu che si assomiglia sempre ai propri padri.
Mi feci afferrare per pazzo e chiamai Spizzuoco:
«Strunz! Ma che cazzo andate facendo?»
«Vado facendo che non vi faccio lavorare».
«E io vi denuncio».
«E io t’accir. Strunz!»
In pratica Spizzuoco si voleva vendicare del licenziamento.
La Madonna non l’aveva aiutato questa volta, e così
aveva pensato di minacciare gli operai. Ci pensai e ci
ripensai, stavo solo a casa, i miei erano partiti per
le vacanze. Io no, perché dovevo leggere un sacco
di libri durante le feste. «Meglio così,
tanto che vieni a fare», aveva detto mio padre.
Ci pensai e ci ripensai, e alla fine decisi di contrattare.
L’indomani, vigilia di Natale, vidi Spizzuoco in
azienda per metterci d’accordo. Lui se ne stava
tutto impettito con due scagnozzi alle spalle. Litigavamo
sul prezzo, quando da lontano vidi arrivare la Range Rover
di Mastrangelo. E adesso questo che voleva? Però,
man mano che si avvicinava la macchina, gli scagnozzi
si allontanavano sempre di più e Spizzuoco perdeva
tutto il contegno.
Mastrangelo fermò la macchina e aprì la
portiera. Sul sedile davanti c’era un fucile a canne
mozze. Poi si avvicinò a me e mi disse: «Ingegnere,
venite con me», e mi tirò via, non tanto
delicatamente. Diciamo mi mise al riparo dietro la sua
macchina.
Quello che vidi lo vidi da dietro la Range Rover di Mastrangelo,
attraverso i finestrini fumè. L’ospite di
Mastrangelo era il potente boss del luogo, il quale scese
dalla macchina e si rivolse ai due i fratelli Cunto: «Quanto
v’ha chiesto ’stu sfaccimm’ e’
merda per lavorare qui?» «Cinque milioni»,
risposero in coro. Al che il boss disse a Mastrangelo:
«Prendi dieci milioni, mettiglieli in tasca e uccidilo».
Una cosa così non l’avevo mai sentita, nemmeno
da Peppe u’ stuort. Tradotta voleva significare:
tu, Spizzuoco, hai il coraggio di venire nella mia zona
e chiedere cinque milioni di tangenti. Ma per chi mi hai
preso, io sono il boss, più potente dei potenti,
e per dimostrartelo te ne do dieci di milioni e poi ti
uccido.
Spizzuoco si inginocchiò e si mise a piangere,
stringendosi alle gambe del boss. Chiedeva perdono e,
veramente, non ho mai più visto una scena così:
tenuto conto della situazione, la dignità era l’ultima
cosa da preservare. Pensavo tra me: perché Spizzuoco
non chiede aiuto alla Madonna, adesso? Fu un pensiero
cinico, di rabbia, in fondo un po’ ero contento
di assistere a quella scena. Ma fu anche l’ultimo
pensiero cinico che ebbi, perché il boss disse:
«Solo perché oggi nasce nostro signore Gesù
Cristo, solo per questo non ti uccido, la Madonna ci resterebbe
male».
In un attimo di consapevolezza capii che spesso il cinismo
degli altri può essere un antitodo al tuo cinismo.
Il potere del boss un antitodo al tuo potere. La Madonna,
Gesu Cristo, i fucili a canne mozze e tutto il resto mi
fecero pensare che stavo in un altro mondo, e che detta
in sintesi: si era fatta ora.
Per me.
Una volta finita – finì tutto velocemente,
con Spizzuoco in fuga, Mastrangelo che mi disse: «Ingegnere
statevi bene, buon Natale a voi e a tutta la vostra famiglia»,
il boss che scomparve così come era apparso e i
Cunto che tornarono a lavorare come nulla fosse successo
– presi la macchina e decisi di raggiungere i miei
genitori in vacanza. Guardavo i Mazzoni, questa terra
dalla geometria semplice, e pensavo che semplice non era
affatto. Agli svolazzi dalla grafia di Mastrangelo, ariosa
come quella di un bambino, corrispondevano fucili a canne
mozze e Madonne che decidevano la vita e la morte. Persone
di una certa età che si mettevano in ginocchio
tra le lacrime e boss che graziavano i condannati. Non
era così semplice, ero io che ero incosapevole.
«Il potere vi vuole stupidi». E io ero diventato
a mio modo un uomo di potere, nei Mazzoni ero un piccolo
e innocuo boss. Mi trattavano bene perché volevano
qualcosa in cambio.
Non era passato molto tempo da quella mattina a teatro
ed ero ancora stupido. Finora i libri non mi avevano aiutato.
Che avesse ragione mio padre?
Così, pieno di dubbi, entrai a casa e lo trovai
in cucina.
Stava davanti alla televisione. Non si girò nemmeno
per guardarmi. Non penso che fosse stato attratto dal
programma, insomma la «Ruota della fortuna»
non l’hai mai interessato. Sapevo che da un minuto
all’altro, cioè nel momento in cui gli avrei
detto che lasciavo tutto, avremmo iniziato a litigare.
Lasciare tutto, un buon posto, per fare poi che?
Ancora non lo sapevo. Lasciare tutto solo perché
avevo avuto paura della strada, della terra, delle mani
sporche di fango, di un mondo che non ero riuscito ad
attraversare.
Quindi gli parlai velocemente, senza perdere tempo, cercando
di evitare quei tranelli che sono le proposizioni ini-dentali,
i balbettiii, i mugugni, tutte cose che, girando attorno
all’argomento, avrebbero acuito i mei sensi di colpa.
Non si girò neppure, però mi disse:
«Bene, bene così. Hai fatto bene».
Dopo qualche minuto venne in camera da letto, dove stavo
per spiegare il fatto a mia madre, e disse:
«Facciamoci una birra».
Nella seconda metà degli anni Ottanta, il settimanale
«l’Espresso» regalò ai suoi lettori
un rompicapo cinese, il Tangram. Sette pezzi geometrici
di varie dimensioni. Il gioco consiste in questo: bisogna
disporre in piano tutti e sette i pezzi in modo da formare
figure riconoscibili, conformi a quelle proposte dai libri
e dai manuali che accompagnano il gioco. È soprendente
vedere la quantità di figure che si possono ottenere
combinando i vari pezzi. Ma questo è un altro discorso.
Il fatto è che per anni lasciai quel gioco in un
ripiano della libreria finché, nel ’92, durante
le pulizie di primavera, lo ripresi in mano. E cominciai
a studiarlo. Non era facile. Guardare la figure sul manuale,
intendo, e poi provare a capire quale fosse l’incastro
che, diciamo così, le poneva in essere. Spesso
sbagliavo: un triangolo isoscele al posto del parallerepipedo,
ed ecco che uno spigolo veniva fuori misura. Il contorno
non tornava. Il gioco sottointendeva che la verità
(su una figura) non è la figura stessa, ma il giusto
incastro tra le sue parti. E il gioco della verità,
l’avrei imparato con il tempo, richiedeva un trucco:
bisognava estraniarsi.
Non starsene lì a provare e riprovare la giusta
combinazione. Sì, d’accordo, ci si poteva
riuscire, ma con troppa fatica, e il tempo perso non valeva
la soddisfazione. Più semplicemente, bisognava
portare la figura con sé, tenerla in mente, provare
a rileggerla senza paura di essere occupati nel frattempo
in faccende domestiche. Poteva succedere che in un attimo
di illuminazione rivedevi lo scheletro della figura.
Così tornavi al tavolo, prendevi i pezzi, e con
pochi gesti ne venivi a capo. Insomma, scoprii che per
fare un incastro giusto bisognava estraniarsi dal contesto.
Spesso la concentrazione ti induce all’errore. E
invece era bello risolvere l’enigma distrattamente.
Quando questo accadeva, avevi l’impressione di scoprire
una regola di vita, e cioè: se portavi una figura
ma non solo, anche un progetto, un’idea, riposte
nel fondo della tua coscienza, se le lasciavi a decantare,
poi tutte le cose mandate avanti nel frattempo, anche
le più banali e quotidiane, servivono alla causa,
alla risoluzione del problema. Ti aiutavano nella messa
a fuoco. Era il mondo che ti circondava a portarti la
soluzione, come quando un barbaglio di luce fa intravedere
la filigrana di una banconota. Anche se le illuminazioni
non hanno memoria, sono come i giorni felici. Subito dopo
aver composto una figura già non ricordavo più
l’esatta combinazione, bisognava aspettare una distrazione
futura.
Peppe u’ stuort e Filippone morirono entrambi qualche
anno dopo, come del resto morirono anche Mastrangelo e
Spizzuoco.
Ma prima di allora, prima della sua morte, avevo rivisto
un giorno Peppe. Non c’era che dire, avevamo avuto
due carriere diverse. Io alla fine ero andato a lavorare
in un ministero. Dopo i Mazzoni, avevo deciso di chiudere
con tutto quello che era ambiguo. Visto come erano andati
i fatti, preferivo adesso, almeno per un po’, restare
metaforicamente sotto lo scivolo a guardare distrattamente
la pioggia.
E come osservatore andai al Blue Notte, un locale che
andava molto di moda. Gli anni Ottanta avevano fatto la
loro epoca. Certo, in provincia il passo non si era completamente
modificato, però la mutazione cominciava a essere
visibile. Il Blue Notte aveva sostituito tutto l’arredamento.
All’eccesso di cose e di colori, di moquette spessa
dieci centrimetri, di griffe e di abbondanza, adesso si
preferiva la misura. Non voglio dire che l’arrendo
era in design, tutt’altro. Il Blue Notte era tornato
indietro, agli anni Settanta. A quel gusto bombato, caldo,
accogliente, come la schiuma di uno shampoo.
Fatto sta che lì all’ingresso c’era
Peppe u’ stuort. Lavorava
come buttafuori e non appena mi vide fece segno di passare
dal retro.
«Non ti preoccupare», gli dissi, «faccio
la fila».
Mi fece allora un altro segno: come vuoi tu, e poi ancora
un altro: ci vediamo dentro.
Avevamo dunque avuto due carriere diverse. Per quello
che ne sapevo, Peppe era diventato il braccio destro di
un usuraio. Filippone spaventava gli insolventi e Peppe,
nel caso, menava. Poi Filippone era morto sparato, non
si sapeva da chi né perché. Qualcuno diceva
che aveva tentato il colpo grosso: suo padre era in ascesa
e lui ne aveva approfittato.
Era morto prima lui, e poi il padre. Allora Peppe si era
fatto un paio di anni di prigione e poi era finito a fare
il buttafuori. Menava ancora. Una volta era intervenuto
in una rissa tra giocatori di basket e ne aveva atterrati
tre. Faceva a pugni nel suo modo tutto particolare, senza
ansia o rabbia. Qualche volta, prima di colpire qualcuno,
si guardava pure intorno.
Non perché cercasse l’applauso degli altri.
Semplicemente, colpire era per lui un atto di routine,
non ci faceva più caso, come il pilota che, quando
l’aereo subisce un contraccolpo e tutti i passegeri
si spaventano e si chiedono l’un l’altro che
cosa sia successo, lui, il pilota, scrolla le spalle e
dice: «un fulmine».
Ma Peppe con gli anni aveva perso anche lui la rabbia
giovanile. Adesso colpiva sbadigliando, come un impiegato
del catasto.
Venne a sedersi accanto a me, e di sicuro voleva dirmi
qualcosa, perché mi guardava negli occhi e cercava
le parole, ma poi avevo l’impressione che non ci
riusciva, quasi balbettava sul più bello. Finimmo
per parlare del più e del meno, gli dissi che adesso
stavo a Roma e che lavoravo al Mini- stero, che stavo
cominciando a scrivere ma ancora non avevo trovato la
mia strada.
«E cioè?», mi chiese
«Cioè...», gli dissi, «cioè
scrivere significa porsi un sacco di problemi. Cioè,
capito. Non puoi, che ne so... per esempio... una cosa
che mi ossessiona: puoi essere contro il potere e usare
il suo stesso stile, o no? Come dire, faccio un esempio,
puoi essere contro i fascisti e usare la voce stentorea
del Duce? In fondo il potere ti vuole stupido, no?»
Siccome Peppe era rimasto con la bocca aperta, io pensai
che non era il caso di fare quella discussione in quella
sede, discussione che poi non sapevo nemmeno dove andava
a parare. Lui mi disse:
«Insomma, ci devi pensare bene alle cose».
«Sì, però, almeno nel mio caso, per
pensare mi devo distrarre. Perdo tempo e spesso non combino
niente, diciamo così». E qui la nostra discussione
si interruppe, perché qualcuno chiamò Peppe.
Uno, nel locale, stava facendo un po’ il buffone
con una ragazza, gli amici di lei se l’erano presa
e stava per scatenarsi una rissa. Vidi Peppe afferrare
per il colletto il Tizio, alzarlo di peso e buttarlo in
un angolo. Lo so cosa faceva in quei casi, il pugno lo
tirava sotto lo zigomo, il malcapitato vedeva la luce
bianca e smetteva per sempre di dare fastidio. Ma Peppe
non lo fece. Anzi, mi guardò. Sul soffitto girava
la palla a specchi, vecchia seduzione dance anni Settanta,
così il locale era pieno di riflessi colorati.
Qualcuno passò pure sul viso di Peppe.
Adesso, io lo so: è il rischio del gioco del Tangram,
provare a ricomporre tutti i pezzi per formare una figura
che abbia un senso, però voglio rischiare: lo sguardo
di Peppe, quella sera, era lo stesso che gli avevo visto
la domenica pomeriggio di tanti anni prima al parco, quando
prese a inseguire i soffioni: tutto contento, insomma,
come qualcuno che aspetta il Natale, la Pasqua, le vacanze
estive, e sa che il tempo è dalla sua parte, che
quell’eccesso di libertà, in fondo, lo preserverà
dai guai a venire. Sarà il suo nucleo irriducibile.
Lo ricordo bene, quello sguardo, perché gliel’ho
visto solo due volte, il pomeriggio al parco e quella
sera al locale. Il disturbatore non venne picchiato, Peppe
si limitò a farlo accomodare a forza di spintoni.
Quel tizio allora era un ragazzino, adesso è una
specie di imprenditore e gira con la Hummer su e giù
per le vie della città.
Non fu proprio l’ultima volta che vidi Peppe, fu
l’ultima che lo vidi vivo. Qualcuno gli sparò
mentre stava in una cabina telefonica con la cornetta
in mano. Esistevano già da tempo i cellulari, ma
Peppe preferiva le cabine. L’avevano coperto con
un lenzuolo e qualcuno mi disse che sotto il velo c’era
Giuseppe Indovino detto Peppe u’ stuort, appunto.
Dopo qualche tempo incontrai Raniero, un mio amico
magistrato, e gli chiesi di Peppe, che ne sapeva lui,
perché era
stato ammazzato?
«Si era fatto fare fesso», mi disse.
Cioè, in pratica, non picchiava più tanto
bene. Non spaccava le bottiglie in testa alla gente per
richiamare tutti ai suoi ordini. Brutto segno, il deperimento
fisico, corrisponde a quello morale. Magari, avranno pensato
quelli che hanno dato l’ordine di farlo fuori, uno
così facilmente si vende a qualcun altro. E in
più si era fregato dei soldi di un lavoretto sporco,
pare che se ne volesse andare a Santo Domingo.
Scappare con il malloppo, dunque. Verso un’isola.
Fare una stronzata, l’ultima, per ottenere la libertà,
è un gesto romantico. A loro modo i gesti romantici,
anche di tanto in tanto e accidentalmente, migliorano
il mondo. E più spesso, invece, si pagano. Peppe
avrà pensato che tutta la vita così, non
poteva passarla, in mezzo a cape di cazzo e futuri imprenditori
buffoni. Il potere ci vuole stupidi, no? Chissà
se quella frase, quel giorno al teatro, non abbia funzionato
un poco anche per lui e magari abbia anche, sommessamente,
lavorato a formare il suo nucleo irriducibile. O forse
è solo la mia ossessione per il Tangram, il Tangram
in letteratura che mi fa dire questo. Fatto sta che non
ce l’ha fatta. Troppo potere intorno a lui, o troppa
stupidità, o forse il suo nucleo non pulsava abbastanza,
o ancora, non aveva parole per esprimerlo al meglio, balbettava
sul più bello. Anche lui, come me, si sarà
trovato in mezzo a un lago di fango e avrà provato
ad attraversarlo, senza sapere quale tecnica usare, fidandosi
del suo istinto, della sua irrequietezza. Dopo il guado
avrà guardato fiducioso la sponda opposta, pensando
è fatta, adesso mi avventuro. E invece qualcuno
stava già dall’altro lato per dirgli: «Si
è fatta ora, Peppe!» Ci ripenso, tutte le
volte che scrivo e sono sempre in ansia per cercare la
speciale figura geometrica in grado di ricompattare tutto.
L’incastro migliore che mi protegga dalla stupidità
a venire. Lo stile che mi sottragga alla collusione. E
per far questo, per cercare la combinazione e il giusto
peso tra le parti, mi distraggo e vado avanti e indietro
nel tempo, penso a Peppe steso nella cabina, al suo sguardo
al Blue Notte, a me in mezzo ai Mazzoni con Mastrangelo,
alla mattina al teatro, a mio padre e a mia madre naturalmente,
al «si è fatta ora» e al cappello con
i paraorecchi. Ci ripenso perché se trovo questa
particolare e specifica figura, potrei con poco, costruire
il surrogato narrativo di quell’anello di gomma
che mio nonno aveva creato, insomma potrei trovare quell’incastro
che migliora e pulisce, di poco, si intende, per quello
che può, il mondo dai detriti e, così facendo,
accidentalmente, regalerei a Peppe ‘u stuort una
morte migliore.
Adesso che è passato tanto tempo, sono io a stare
seduto su una panchina a guardare Alfredo giocare, e guardandolo
cerco di ricordarmi di quando c’ero io, al suo posto.
E rivedo quei particolari sguardi, di mio padre e di mia
madre, su di me.
Se faccio attenzione e mi concentro, forse potrò
immaginare i passi di Alfredo da qui a qualche anno, costruire
appunto una combinazione perfetta con tutti i pezzi, quelli
già usati e quelli che mancano.
Eppure. Eppure lo guardo e mi viene il sospetto non potrò
far nulla, nulla che segni il suo passo una volta per
tutte,
tranne forse lasciarlo giocare a maniche corte o spingerlo
a
correre sotto la pioggia.
Per il resto, dovremo fidarci l’uno dell’altro,
e perdonarci a vicenda ogni errore, ogni rispettiva irrequietezza
presente e futura, ma con tempi sfalzati. Dovremo cioè
ragionarci in seguito. Perché comunque tutto il
suo cammino sarà accidentale, una questione di
casuale illuminazione in grado di mostrare la filigrana
del bivio: se cioè le strade che un giorno si biforcheranno
davanti ai suoi passi finiranno nel fango o andranno dritte
verso la meta.
Senza considerare poi il fatto che, nell’uno o nell’altro
caso, ammesso che Alfredo vorrà attraversare come
me il lago di fango, lo farà senza sapere mai in
anticipo se sull’altra sponda si viva meglio o peggio.
(da Si è fatta ora, minimum fax, 2006)
Antonio Pascale è nato a Napoli
nel 1966, ha vissuto prima a Caserta poi a Roma, dove
attualmente lavora. Ha pubblicato per Einaudi La
città distratta (2001, premio Onofri e premio
Elsa Morante), La manutenzione degli affetti
(2003, premio Napoli, premio Chiara, premio Il Ceppo,
premio Loria, premio Ostia-Città di Roma) e
Passa la bellezza (2005, premio Croce). Per Laterza
ha pubblicato Non è per cattiveria e
per la minimum fax Si è fatta ora (2006).
Scrive per la televisione e per la radio. Collabora
con “Il mattino” e le pagine romane
della “Repubblica”.
|



