| |
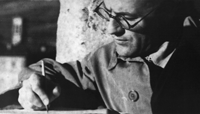 Arturo
Loria nasce a Carpi (Modena) il 17 novembre 1902, quarto
di otto figli di Aristide Loria, industriale ebreo,
ed Antonietta Righi, cattolica. Nei primi mesi di vita
è colpito dalla poliomelite, che lo segnerà
per tutta la vita rendendolo leggermente claudicante. Arturo
Loria nasce a Carpi (Modena) il 17 novembre 1902, quarto
di otto figli di Aristide Loria, industriale ebreo,
ed Antonietta Righi, cattolica. Nei primi mesi di vita
è colpito dalla poliomelite, che lo segnerà
per tutta la vita rendendolo leggermente claudicante.
Agli inizi del Novecento il padre apre a Carpi una fabbrica
di cappelli di paglia; l’attività si sviluppa
con successo, tanto che nel 1912 l’imprenditore
decide di trasferirsi con la famiglia a Firenze, dove
impianta una manifattura che estende la propria produzione
ai feltri. Dal 1916 Loria frequenta il Regio Liceo Classico
Galilei di Firenze. Oltre alla cultura classica, latina
e greca, la sua attenzione si rivolge in particolare
alle letture straniere, con precoce predilezione per
Shakespeare, Poe, Dostoevskij ed Emily Dickinson. A
diciotto anni, nel 1920, compie il suo primo viaggio
a Parigi; in autunno nascono le sue prime prove narrative.
Nel 1921 si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Pisa (dove conseguirà
la laurea), prendendo in affitto una stanza sui lungarni
vicino a Ponte Solferino.
A partire dal 1922 inizia una sistematica produzione
di racconti. Nel 1926 alcuni di essi vedono la luce
su «Solaria». Inizia l’assidua frequentazione
del gruppo di giovani intellettuali e scrittori che
gravitano attorno alla rivista fiorentina. Le riunioni
si tengono al celebre Caffè delle Giubbe Rosse
di Piazza Vittorio Emanuele II. Loria conosce Alberto
Carocci, stringe amicizia con Roberto Papi, Giovanni
Colacicchi e Alessandro Bonsanti, frequenta Eugenio
Montale, Raffaello Franchi, Felice Carena, Marino Marini.
Nel clima stimolante che contrassegna l’attività
del periodico incontra pure Giuseppe Ungaretti, Elio
Vittorini, Carlo Emilio Gadda.
All’uscita della prima raccolta, Il cieco
e la Bellona del 1928, il lavoro di Loria è
favorevolmente accolto dalla critica. Notevoli consensi
(tra cui quello di Cecchi) raccoglie pure la seconda
raccolta, Fannias Ventosca, pubblicata nel
1929 presso l’editore torinese Buratti. La
scuola di ballo, terzo volume di racconti, esce
infine nel 1932, per le Edizioni di «Solaria»
come il primo. Con questo libro Loria si pone di nuovo
al centro dell’attenzione letteraria, con prestigiosi
giudizi di Giansiro Ferrata, Guido Piovene e Giuseppe
De Robertis. Vince il Premio Umberto Fracchia, istituito
dalla rivista «L’Italia letteraria»
che nel febbraio del 1933 gli dedica un ampio omaggio.
Nel luglio di quell’anno la famiglia Loria si
trasferisce al Pellegrino, una grande villa alle porte
della città. Qui lo scrittore abiterà
fino alla morte in un appartamento separato dal resto
dei familiari: è proprio nello studio collocato
nella mansarda della nuova dimora, che in quei mesi
si definisce con chiarezza il progetto di un romanzo
a sfondo autobiografico, Le memorie inutili di Alfredo
Tittamanti.
Invitato dall’amico Dino Bigongiari, professore
di filologia romanza alla Columbia University di New
York, nell’autunno del 1933 Loria va negli Stati
Uniti per un semestre di insegnamento alla Casa Italiana
diretta da Prezzolini. Un altro breve soggiorno americano
risale all’estate del 1936.
Quando nel 1937 Bonsanti fonda «Letteratura»,
lo scrittore entra a far parte dei collaboratori della
rivista. Affitta uno studio in Borgo San Jacopo, una
torre con vista panoramica su Firenze. Intanto la situazione
politica va drammaticamente precipitando verso nuove
limitazioni delle libertà fondamentali: tra il
luglio e il novembre del 1938 sono emanate le leggi
razziali che vietano agli ebrei di esercitare una vastissima
serie di professioni e attività, emarginandoli
di fatto dalla vita del paese.
Loria riesce ancora a pubblicare uno dei suoi racconti,
L’albergatore malato, sulla rivista «Circoli».
Nel 1938 comincia a scrivere la prima di una serie di
opere teatrali, I colloqui del Principe. Durante
il 1941 escono a puntate su «Argomenti»
parti delle Memorie inutìli. Nel 1942
lavora al dramma satiresco Endymione del quale
l’anno successivo compariranno il primo e il secondo
atto su «Letteratura», a firma Lorenzo Valla.
Dal marzo del 1942 Loria tiene un diario, il Giornale
di bordo, nel quale quotidianamente registra avvenimenti
di piccola e grande importanza, tracce di vita intima,
riflessioni di carattere generale, cronaca. Lo scrittore
mantiene ben saldi i rapporti di amicizia, in particolare
con Colacicchi e Papi; continua a frequentare Bernard
Berenson nella sua residenza di Settignano, ed è
in contatto con Massimo Bontempelli, Tommaso Landolfi,
Roberto Longhi, Giorgio Morandi, Alberto Savinio.
L’aggravarsi della situazione storica costringe
la famiglia Loria a lasciare Firenze e rifugiarsi a
Montevarchi. Nell’agosto del 1944, nell’eplosione
dei ponti sull’Arno ad opera dei tedeschi, viene
distrutto l’ufficio fiorentino della ditta Loria
in Por Santa Maria: nel crollo lo scrittore perde importanti
manoscritti, vedendo in tal modo cancellati «dieci
anni di lavoro silenzioso e abbastanza assiduo».
Con la fine della guerra la fabbrica dei Loria a Montevarchi
riprende la propria attività, ma la villa del
Pellegrino è stata saccheggiata dai tedeschi
e nella devastazione anche la ricca biblioteca e la
collezione di quadri di Arturo sono andate perdute.
Nel 1945 lo scrittore fonda e condirige, assieme a Montale,
Bonsanti e Scaravelli, «Il Mondo», un periodico
di cultura militante calato nell’attualità
della ricostruzione. Loria vi si impegnerà con
articoli di ispirazione civile e politica. In questo
clima si iscrive al Partito d’Azione ed è
tra i fondatori del Circolo Culturale Fratelli Rosselli.
Sempre nel 1945 pubblica sulla nuova rivista di Piero
Calamandrei «Il Ponte» un estratto del Diario
senile. Lavora frattanto alla stesura di poesie,
parte delle quali confluiranno nel postumo Bestiario,
edito nel 1959 per le cure dell’amico Bonsanti.
Su «Letteratura» compare nel 1946 il terzo
ed ultimo atto di Endymione, opera che uscirà
in volume l’anno dopo. Il 1949 registra un’intensa
attività di Loria come traduttore: esce per Electa
il volume di Berenson Abbozzo per un autoritratto.
Viaggia molto (Francia, Svizzera, Inghilterra) per conferenze,
il cui tema prediletto è la letteratura americana
dell’Ottocento, con i suoi grandi scrittori: Poe,
Hawthorne, Melville, Whitman. Tra la fine del 1948 e
la fine del 1951 perde i genitori: prima l’«adorata»
madre Antonietta, poi il padre.
Nel 1953 intraprende una nuova collaborazione con Berenson,
traducendone gli scritti per il «Corriere della
Sera». Sullo stesso quotidiano appaiono alcune
delle sue favole, da lui in seguito organizzate in libro
(Settanta favole). Ma Loria è ormai
un autore isolato, davvero «disperso e inascoltato»,
estraneo ai nuovi climi letterari e ai meccanismi dell’industria
culturale che si muove attorno a lui.
Muore a Firenze il 15 febbraio del 1957. Tre anni dopo
escono da Mondadori, con prefazione di Giansiro Ferrata,
i racconti del Compagno dormente.
(da Arturo Loria. Carpi, Firenze e dintorni. Fotografie
di Valerio Rebecchi, testi di Marco Marchi, Fondazione
Fossoli e Comune di Carpi, 2002)
|



